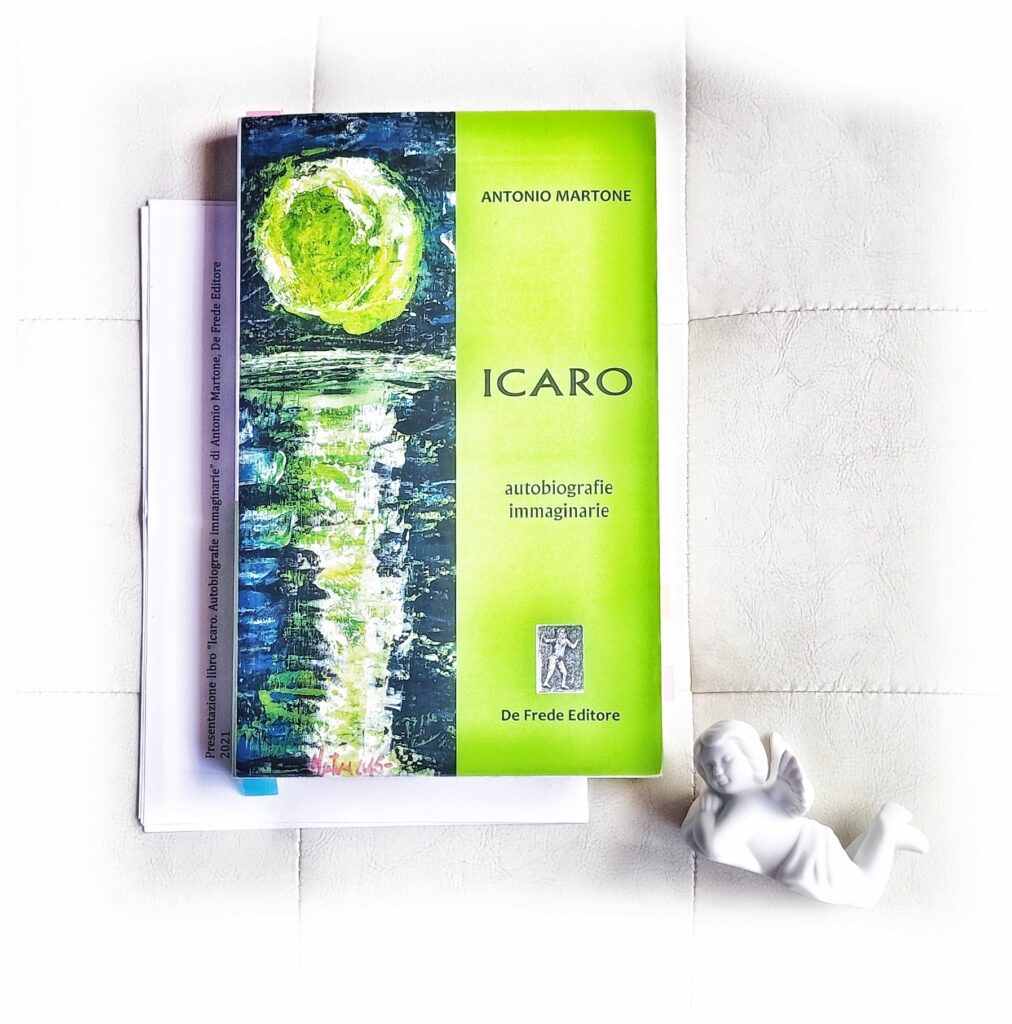L’era della civiltà greca è stata uno dei periodi più affascinanti e coinvolgenti che la Storia abbia mai attraversato. E per chi, come me, desidera esplorare la contemporaneità attraverso la mitologia e la filosofia, certi libri sono preziosi per immergerci e rievocare la magia di questa antica cultura.
Ecco perché, quest’oggi, suggerisco la lettura del testo del prof. Antonio Martone, docente di Filosofia politica presso l’Università di Salerno, denominato Icaro. Autobiografie immaginarie, pubblicato da De Frede Editore, Napoli 2021.
Il titolo dell’opera è emblematico: attraverso il richiamo alla storia di Dedalo e di Icaro, miti fra i più conosciuti del mondo greco e leggenda che non smette mai di ispirare nuove storie e novelle, l’autore ci offre un alibi perfetto per discorrere del tema dell’identità, dell’ostinata ricerca delle ragioni d’essere dell’uomo, nonché uno strumento utile per (ri)conoscere – e gestire – le crisi esistenziali nella società moderna.
“La caduta delle maschere”, “Il morso della modella”, “Estasi e follia” sono tre spunti letterari finalizzati alla narrazione delle variegate sfaccettature di tre Icaro moderni. Il libro si colloca nella tradizione del romanzo filosofico e induce a riflettere sul valore dei “ricordi”, tesoro inestimabile della mente di ciascuno di noi, attraverso cui (ri)costruiamo la nostra personale biografia, in quanto ancoraggio, stimolo, pretesto, o magari condanna, della cruda e nuda realtà.
«Viene portato alla luce con chiarezza, fino a mostrarli congiunti in un movimento unico, il contrasto fra il bisogno di felicità e le tante angosce a cui è sottoposto l’uomo contemporaneo».
In queste mie “divagazioni sul mito”, che aprono vari interrogativi, ho considerato il volo e la caduta del giovane Icaro tenendo conto di una duplice chiave interpretativa, suggerita sia dalle caratteristiche dei personaggi illustrati, sia da ulteriori approfondimenti che ho affrontato personalmente. Nel corso dell’esistenza, ci si può muovere in due modi: ci si può abituare a volare “a bassa quota”, ossia accontentarsi di vivere nella mediocrità, in completo anonimato, senza avere il coraggio di osare, senza slanci né sogni da realizzare, oppure si può cercare di volare in alto, pur con la consapevolezza di poter “cadere”, ma provando comunque a rialzarsi, senza lasciarsi trascinare a fondo da quelle “ali bagnate”, che rappresentano, nella trasfigurazione del mito, le nostre capacità interiori, punto di forza o di debolezza a seconda del caso.
Del resto, già Nietzsche, in Così parlò Zarathustra, scriveva che l’essere umano è «una corda tesa sopra un abisso. Un pericoloso andare al di là, un pericoloso essere in cammino, un pericoloso guardarsi indietro, un pericoloso rabbrividire e fermarsi. […] Io amo coloro che non sanno vivere se non come quelli che vanno in rovina, perché essi sono quelli che vanno oltre».
«La storia è fatta di ombre spesse e inaccessibili come il cuore stesso dell’uomo».
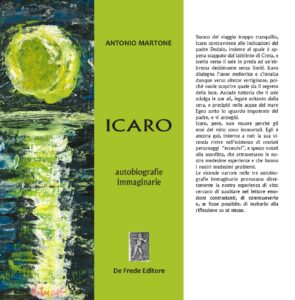 Sulla scorta di quanto letto in queste pagine, mi sono chiesta perché l’umanità sia così tanto esposta al fallimento. Non è affatto un caso che le ali disarticolate di Icaro ci ricordino che l’individuo non possiede gli strumenti per dominare la propria natura (la caduta è provocata dallo scioglimento delle ali di cera – il mezzo – e non dalla combustione del corpo di Icaro che si avvicina troppo al sole – che rappresenta, invece, il divino inaccessibile, la zona d’ombra impenetrabile).
Sulla scorta di quanto letto in queste pagine, mi sono chiesta perché l’umanità sia così tanto esposta al fallimento. Non è affatto un caso che le ali disarticolate di Icaro ci ricordino che l’individuo non possiede gli strumenti per dominare la propria natura (la caduta è provocata dallo scioglimento delle ali di cera – il mezzo – e non dalla combustione del corpo di Icaro che si avvicina troppo al sole – che rappresenta, invece, il divino inaccessibile, la zona d’ombra impenetrabile).
Come non scorgere in queste movenze del mito una potentissima metafora perfettamente in grado di connotare la società attuale? Viviamo una dipendenza dai social media, un non-luogo dove impera l’assenza d’interesse per l’altro da sé, nella convinzione di essere al centro dell’universo. Si assiste, da tempo, al dilagante fenomeno dell’ipertrofia dell’Io. Ma qual è la causa di questo atteggiamento? Assenza di amore, assenza di dialogo? Egocentrismo, intolleranza?
«In fondo ciò che voi volete è solo una finestra sulle mie emozioni».
Probabilmente tutto questo ed altro ancora: siamo così alienati, insofferenti, tormentati, egotici, da aver perduto il senso di ciò che ci circonda. Si potrebbe perfino affermare che non sappiamo più neppure distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è. E allora, che cosa ne consegue? Per la perdita di comprensione e di amore, bisogna concluderne che l’unico prezzo da pagare sia soltanto la perdita totale della coscienza e della razionalità, come è egregiamente esposto nel terzo racconto, ossia “Estasi e Follia”? Non meritiamo una via di fuga, una nuova Itaca cui approdare?
Mentre rimugino su quali siano le risposte (giuste?) a tali domande, nella mia mente prende corpo la consapevolezza dell’inganno: l’inganno della ragione, l’inganno dell’emozione incontrollata, l’inganno di una razionalità che vuole, come quella di Icaro, sfidare il destino. Mi sovviene uno dei monologhi più celebri del recente cinema italiano, la scena finale de La grande bellezza di Paolo Sorrentino:
«Finisce sempre così, con la morte.
Prima però c’è stata la vita, nascosta sotto i bla, bla, bla, bla, bla.
È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore:
il silenzio e il sentimento,
l’emozione e la paura,
gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza
e poi lo squallore disgraziato e l’uomo miserabile.
Tutto sepolto dalla coperta dell’imbarazzo
dello stare al mondo. Bla. Bla. Bla. Bla.
Altrove, c’è l’altrove. Io non mi occupo dell’altrove.
Dunque, che questo romanzo abbia inizio.
In fondo, è solo un trucco. Sì, è solo un trucco».