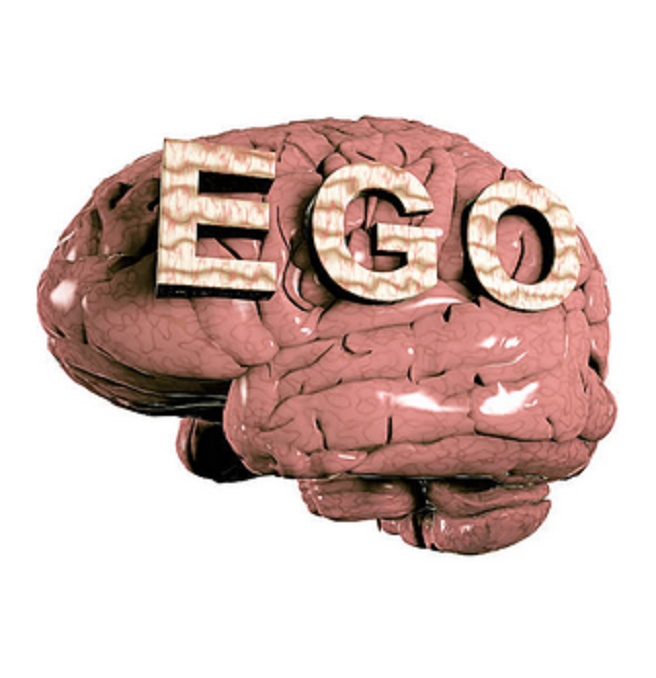Il presente articolo analizza tre tratti centrali della soggettività contemporanea – l’egoismo, l’edonismo e l’attaccamento ipocrita al sistema di credenze – collocandoli entro una cornice filosofica, psicologica e sociologica. Attraverso una prospettiva interdisciplinare, si mettono in luce le contraddizioni e le implicazioni etico-sociali di tali fenomeni, ponendo interrogativi sulla tenuta delle strutture valoriali e sulla deriva individualistica che caratterizza il nostro tempo. L’analisi si conclude con una proposta di ri-orientamento etico basata sulla responsabilità dialogica e la coerenza esistenziale.
- L’egoismo come fondamento della soggettività neoliberale
Nel contesto postmoderno, l’egoismo non è più percepito come un vizio da correggere, ma spesso viene rivendicato come legittima espressione dell’autonomia individuale. La soggettività contemporanea è stata riformulata attorno all’idea di self-interest, promossa dal paradigma neoliberale, secondo cui l’agente razionale massimizza il proprio benessere in un mercato concorrenziale di beni, relazioni e visibilità.
Tale configurazione dell’egoismo ha una doppia origine: da un lato, l’indebolimento delle comunità tradizionali e dei legami solidaristici; dall’altro, la retorica della self-empowerment veicolata dai media e dalle culture digitali. L’individuo si costruisce come impresa di sé, secondo una logica di branding personale che trasforma ogni aspetto dell’esistenza – affetti, emozioni, ideali – in capitale simbolico spendibile.
Questo egoismo sistemico, tuttavia, genera una solitudine strutturale: la centralità del sé esclude la reale alterità dell’altro, che viene ridotto a strumento o ostacolo. La relazione perde la sua valenza etica (Levinas) e viene surrogata da legami effimeri, performativi, spesso finalizzati a una gratificazione immediata.
- L’edonismo come ideologia dell’immediatezza
Parallelamente, l’edonismo si è affermato come principio regolativo dell’esperienza. La ricerca del piacere, già tematizzata da Epicuro in chiave filosofica e moderata, è oggi degenerata in una forma compulsiva e consumistica. Il piacere non è più inteso come equilibrio o felicità duratura (eudaimonia), ma come eccitazione momentanea, emozione rapida, dopamina experience.
L’edonismo contemporaneo è alimentato da un sistema di mercato che vende esperienze anziché beni, promette soddisfazioni personalizzate e stimola desideri infiniti, creando insoddisfazione strutturale. In questo contesto, l’uomo edonista diviene prigioniero della sua stessa libertà desiderante, incapace di gestire l’attesa, il limite e il fallimento. Il nowism – la dittatura del presente – riduce ogni orizzonte progettuale e ogni tensione verso l’altro, generando una cultura della distrazione e della dispersione.
Il legame tra edonismo e disimpegno è evidente: l’appagamento individuale diventa misura di valore, mentre le domande esistenziali, etiche e politiche vengono derubricate come “pesi” o “negatività” da evitare. Il dolore, la responsabilità, la complessità vengono rimossi a favore di una narrazione anestetizzata dell’esistenza, nella quale tutto dev’essere “leggero”, “fluido” e “positivo”. Se poi l’edonismo diventi una ricerca affannosa e smisurata di comportamenti dissennati e psicopatologici, certamente le cause saranno da individuare nella società contemporanea che ne garantisce la diffusione e l’ampiezza. “Sesso, droga e rock’n’roll”, famosa frase nata nel 1969 e poi propagandata in maniera pervasiva nel 1977 attraverso l’incisione del disco del cantante Ian Dury, sembrano gli epistemi su cui, il lercio e il marcio della condotta individuale – fortunatamente non di tutti, ma di una buona parte – vadano a rappresentarne bene l’idea.
- L’attaccamento ipocrita al sistema di credenze: tra cinismo e autoassoluzione
In questo quadro si innesta l’attaccamento ipocrita al sistema di credenze, inteso come adesione formale a principi etici, religiosi o politici che non trovano riscontro nella prassi quotidiana. L’individuo contemporaneo, spesso, non rinuncia ai grandi valori – libertà, giustizia, solidarietà – ma li trasforma in etichette decorative, segni di appartenenza simbolica piuttosto che impegni concreti.
Tale attaccamento ipocrita si manifesta attraverso due modalità: il moralismo delegato (si predica per gli altri ciò che non si pratica per sé) e il cinismo postmoderno (si sa di non credere, ma si continua a recitare il ruolo credente per convenienza sociale o identitaria). Come ha osservato Slavoj Žižek, “si sa bene cosa si fa, ma lo si fa comunque”: questa scissione tra sapere e agire è alla base della tolleranza di massa verso l’ingiustizia e della paralisi etica che accompagna la maggioparte delle scelte politiche.
Il sistema di credenze, svuotato dall’interno, diventa una forma di comfort ideologico: si aderisce per non sentire il vuoto, per non dover pensare in modo autonomo e critico. L’ipocrisia diventa così un meccanismo di protezione dalla responsabilità e un anestetico contro il disagio morale. Non si tratta più di credere, ma di “fare finta di credere” per non destabilizzare l’ordine delle cose. Non si contesta, non si partecipa, non si aderisce, non si critica, non si sviluppa un pensiero autonomo, non si agisce: è l’impatanamento nelle sabbie mobili di amebe copiosamente ricoperte da schemi farisaici di indottrinamenti condizionati e condizionanti.
- Verso una soggettività etica: alternative alla deriva narcisistica
L’intreccio tra egoismo, edonismo e ipocrisia produce una forma di soggettività fragile, narcisistica e alienata, che rischia di disgregare il tessuto comunitario e la capacità collettiva di progettare alternative. La dissoluzione del legame sociale e la delegittimazione della coerenza etica minano la possibilità stessa di una convivenza fondata sul rispetto e sulla giustizia.
Di fronte a questa deriva, è necessario ripensare la soggettività a partire da alcune coordinate alternative:
- La responsabilità dialogica (Buber, Habermas), che restituisce centralità all’incontro autentico con l’altro, riconosciuto come interlocutore degno e non come mezzo.
- La coerenza esistenziale, intesa come allineamento tra credenze e azioni, tra intenzioni e comportamenti.
- La capacità di rinuncia e attesa, contro l’immediatezza edonista, riscoprendo il valore della pazienza, della cura e della profondità relazionale.
Non si tratta di negare il valore del piacere o dell’autonomia, ma di ricollocarli entro un orizzonte etico più ampio, che non eluda la responsabilità e non fugga dal confronto con la finitezza.
Egoismo, edonismo e attaccamento ipocrita al sistema di credenze sono sintomi di un disagio più profondo, quello di una società che ha perso il senso del limite, della responsabilità e della verità interiore. In un’epoca in cui tutto è liquido, riconnettere pensiero e azione, piacere e giustizia, sé e comunità rappresenta una sfida imprescindibile per ripensare la soggettività e salvaguardare la dignità dell’umano. Solo una rivoluzione etica – lenta, quotidiana e coerente – potrà opporsi al nichilismo travestito da libertà.